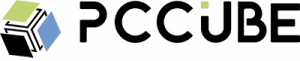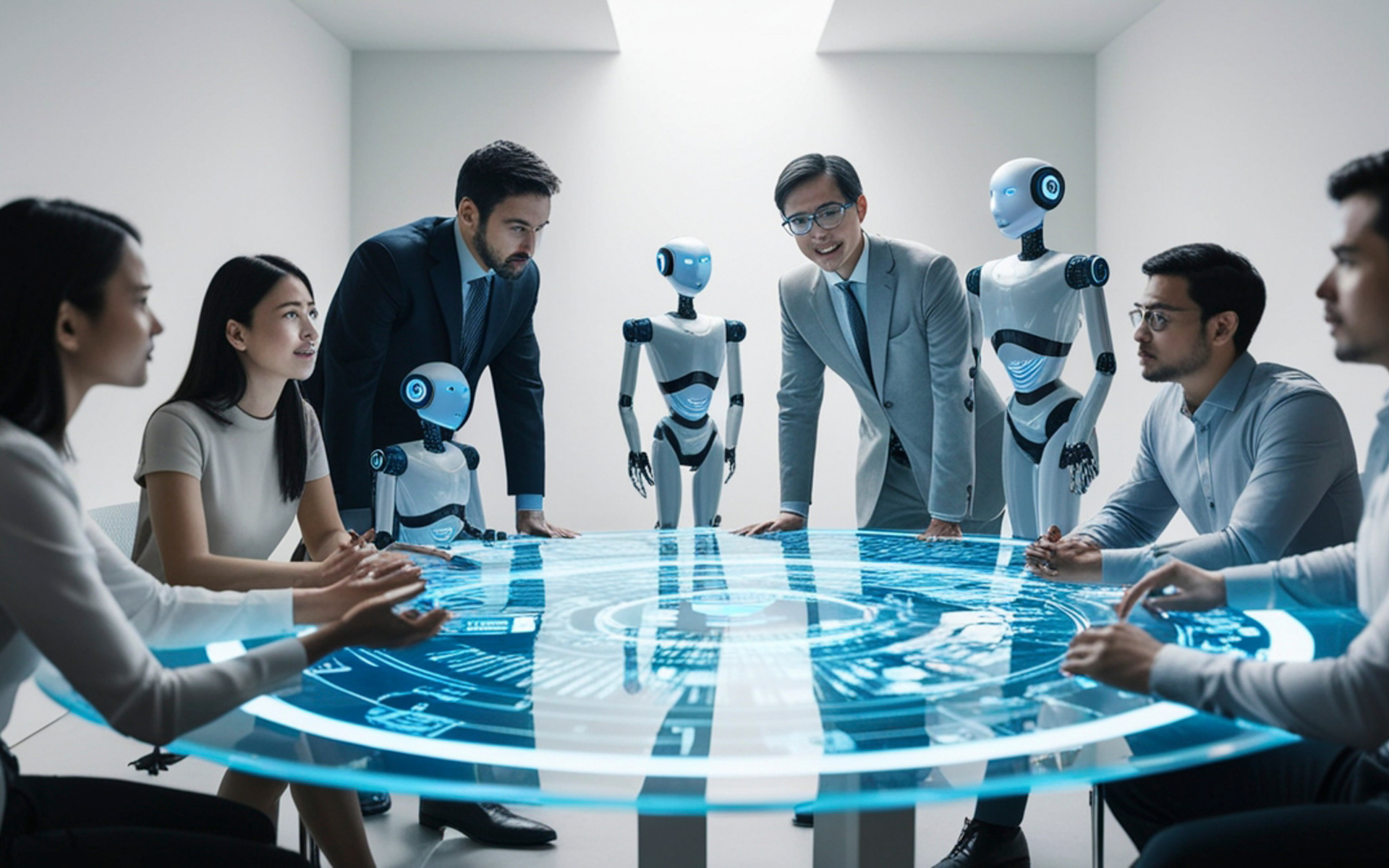Cyberattacchi che hanno cambiato la storia
Nel mondo iperconnesso in cui viviamo, la sicurezza informatica è diventata una questione geopolitica, economica e sociale. I cyberattacchi non sono più semplici incursioni digitali, ma strumenti di potere, sabotaggio e manipolazione. Alcuni di essi hanno avuto un impatto così rilevante da modificare non solo la sicurezza di reti e infrastrutture, ma la stessa direzione degli eventi storici.
Studiare i cyberattacchi che hanno fatto la storia significa comprendere come il conflitto si sia spostato dal campo fisico a quello digitale. Dalle centrali nucleari ai sistemi elettorali, dalle reti bancarie ai dati personali, i bersagli sono cambiati — ma le conseguenze restano profondamente reali.
Stuxnet: il primo attacco cibernetico su scala industriale
Nel 2010 il mondo scoprì l’esistenza di Stuxnet, un malware così sofisticato da far pensare fin da subito a un’operazione statale. Il codice, progettato per colpire le centrifughe iraniane dell’impianto nucleare di Natanz, fu il primo esempio noto di un’arma digitale capace di danneggiare infrastrutture fisiche.
Stuxnet non si limitava a infettare i computer: modificava in modo invisibile il comportamento dei macchinari industriali, distruggendoli lentamente. Secondo molte fonti, fu il risultato di una collaborazione tra Stati Uniti e Israele nell’ambito della cosiddetta Operation Olympic Games. Questo attacco ha segnato una svolta: da quel momento, i cyberattacchi entrarono ufficialmente nel lessico militare globale.
Sony Pictures: un attacco che ha coinvolto la libertà d’espressione
Nel 2014, Sony Pictures fu vittima di un attacco devastante. I file interni, le email dei dirigenti, dati sensibili e film inediti furono rubati e pubblicati online. La responsabilità fu attribuita al gruppo Guardians of Peace, con legami riconducibili alla Corea del Nord.
Il motivo dell’attacco? La distribuzione del film satirico The Interview, che prendeva in giro il leader nordcoreano Kim Jong-un. Oltre al danno economico, l’attacco sollevò una questione delicatissima: può una nazione straniera influenzare la libertà artistica e decisionale di una major hollywoodiana tramite strumenti digitali?
Sony Pictures è stato uno dei primi casi in cui un cyberattacco ha avuto conseguenze culturali e politiche su scala globale.
Wannacry: il ransomware che ha bloccato ospedali e imprese
Nel maggio del 2017, il ransomware WannaCry ha infettato più di 200.000 computer in oltre 150 Paesi. Il codice si diffondeva sfruttando una vulnerabilità nei sistemi Windows — un exploit che sarebbe stato originariamente sviluppato dalla NSA statunitense, poi trapelato pubblicamente.
WannaCry bloccava l’accesso ai file e chiedeva un riscatto in bitcoin. Tra le vittime ci furono anche ospedali del sistema sanitario britannico (NHS), che si trovarono nell’impossibilità di accedere alle cartelle cliniche o gestire emergenze.
Questo attacco ha mostrato come le vulnerabilità informatiche non siano solo un rischio per le aziende, ma anche per la salute pubblica e la sicurezza nazionale. È stato un punto di svolta nella percezione del rischio cyber da parte delle istituzioni.
SolarWinds: il cavallo di Troia nei cuori delle agenzie governative
Nel 2020, l’azienda americana SolarWinds è diventata l’involontario vettore di uno dei più vasti attacchi di spionaggio cibernetico della storia. Gli hacker, legati secondo diverse fonti ai servizi segreti russi, inserirono codice maligno all’interno di un aggiornamento software distribuito a migliaia di clienti — inclusi dipartimenti del governo USA.
Una volta installato, il malware forniva accesso prolungato e invisibile a dati riservati. Per mesi, gli attaccanti hanno potuto osservare documenti interni di agenzie come il Dipartimento del Tesoro, della Giustizia e della Sicurezza Interna.
SolarWinds ha dimostrato che anche software affidabili possono diventare cavalli di Troia digitali, e che la supply chain del software è un fronte vulnerabile quanto i confini fisici di uno Stato.
Pegasus: lo spionaggio nell’era degli smartphone
Un altro capitolo fondamentale nella storia dei cyberattacchi è quello di Pegasus, il software di sorveglianza sviluppato dalla società israeliana NSO Group. Progettato per combattere il terrorismo, Pegasus è stato utilizzato da diversi governi anche per spiare attivisti, giornalisti, politici e oppositori.
Il software era in grado di infettare uno smartphone senza che l’utente compisse alcuna azione — una tecnica definita zero-click exploit. Una volta installato, Pegasus poteva accedere a messaggi, microfono, telecamera e persino geolocalizzazione in tempo reale.
Il caso ha acceso un dibattito globale sul tema della sorveglianza, sulla privacy e sul limite etico tra sicurezza nazionale e violazione dei diritti umani. Pegasus non ha solo cambiato il modo in cui si fa spionaggio: ha modificato il rapporto tra tecnologia, potere e libertà individuale.
I cyberattacchi sono già parte della storia
I cyberattacchi non sono eventi futuri: sono già realtà. Alcuni di essi hanno provocato danni economici ingenti, altri hanno influenzato la geopolitica, la cultura e la percezione pubblica del digitale. I confini tra guerra informatica, sabotaggio economico e crimine organizzato sono sempre più sfumati.
Capire quali sono i cyberattacchi che hanno cambiato la storia è essenziale per comprendere quanto sia fragile e interdipendente il nostro mondo digitale. In un’epoca in cui la tecnologia è ovunque, la sicurezza informatica non è più un dettaglio tecnico: è una priorità strategica globale.